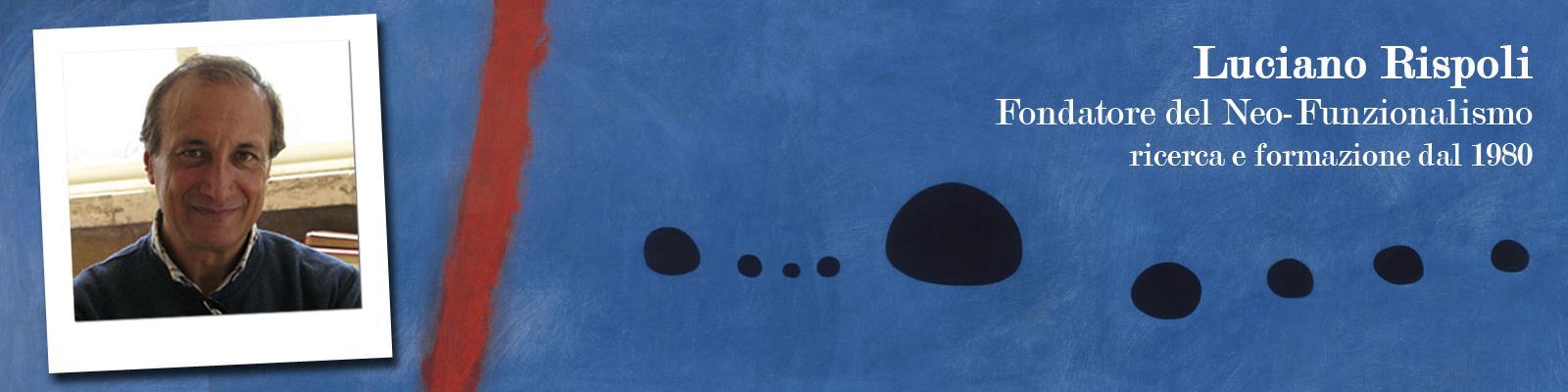Scuola di specializzazione in psicologia scolastica e differenziale, 1981.
L. Rispoli, B. Andriello, G. Palladino.
L’esperienza di tirocinio biennale ha avuto come oggetto di lavoro l’analisi dello sviluppo della relazione madre—bambino durante tutto il primo anno di vita, da una parte; dall’altra un attività di colloqui terapeutici all’interno del Consultorio di Salute mentale del quartiere Stella, almeno fino all’interruzione forzata dovuta al sisma del 23 novembre. L’osservazione del rapporto madre—bambino è iniziata per me già a partire del primo anno di tirocinio, mentre solo dal secondo anno si sono svolti i colloqui di consultazione. Questo criterio di gradualità, quasi propedeutica, ha potuto evidenziare in pieno, a mio avviso, tutto il valore formativo dell’esperienza di osservazione, specie se si tiene conto della ricchezza dei contributi che il gruppo di docenti e tirocinanti apportava discutendo sui resoconti delle sedute.
L’esperienza dei colloqui nel consultorio, pur essendo strettamente collegata ad analoghe modalità di relazione, mi è sembrato che potesse rappresentare più esplicitamente un modello di intervento per lo psicologo; nel senso di saper mantenere un delicato equilibrio tra l’entrare dentro, coinvolgendosi nei problemi che si affrontano, e il saperne tenere una certa distanza, che per metta una riflessione critica e un distinguere ciò che è all’interno di se, e ciò che è della situazione e degli altri. In effetti alcuni di noi, come tirocinanti, siamo stati inseriti operativamente in prima persona nell’attività clinico—territoriale del Centro di salute mentale, pur restando esterni all’Istituzione. Al tempo stesso eravamo però parte di un gruppo di discussione—controllo (formato da docenti che sono anche operatori del settore) venendo così ad assumere una posizione contemporaneamente interna ed esterna sia alla struttura didattica sia a quella di attività clinica. Questo ha permesso di sperimentare identificazione e distanza non solo con il materiale oggetto di discussione, ma anche col proprio vissuto emotivo. In altre parole vivere la contraddittorietà tra l’agire, l’esprimere soluzioni, l’andare verso e, il conoscere il sentire, l’accogliere, permette di accettare l’ambiguità e i limiti ad essi connessi; ma non in termini di esclusione o di scissioni di parti del sé. Il gruppo di discussione ha avuto inoltre una funzione di sostegno e di contenimento, non solo por il contenuto degli argomenti riportati, ma anche perchè, strutturando uno spazio che comunque accogliesse il resoconto delle esperienze, ha assunto un ruolo come di “terza persone reale” nella relazione a due tirocinante—utente. La difficoltà iniziale ad accettare la metodologia dell’osservazione, a sperimentare una dimensione di accogliere più che di intervenire attivamente, veniva evidenziata dalle discussioni di gruppo sui casi e i resoconti riportati. L’analisi a volte dettagliata delle sequenze e la proposizione di continui e diversi modelli interpretativi erano, ad esempio, da me percepite quasi come un sentirmi privare di esperienze vissute come mie proprie e che poco corrispondevano, e potevano corrispondere, ai livelli di comunicazione verbale, e comunque ai discorsi che venivano fatti. D’altra parte questo comportava una situazione psicologica di destrutturazione cui, cioè, schemi logici precostituiti sembravano inadeguati a inquadrare la complessità dei fenomeni reali, e ad offrire soluzioni definitive. Debbo dire che questa situazione mi ha portato a sentire (più che a capire), ad entrare in contatto con profonde risonanze emotive e a sperimentato dall’interno ciò che Minguzzi definisce come messa in discussione dell’onnipotenza; ma non, a parer mio, nei senso di delusione degli “apprendisti stregoni”, bensì come percezione dei limiti e della differenziazione tra soggetto e getto. E’ proprio la discussione del protocollo di osservazione, più che del comportamento e dell’operato del tirocinante, a fornire un elemento importante di distanza e mediazione con il gruppo. Ciò permette a ciascuno di modulare questa distanza: di mettersi in discussione in prima persona, ma anche, quando è necessario, di ritirarsi dentro di sé e percepire differenze e separazioni dagli altri; un pò come avviene tra osservatore e madre, che hanno come spazio riempito, tra loro, il bambino, elemento di comunicazione—separazione. Tra le esperienze realizzate in questi due anni di tirocinio, intendo qui soffermarmi su quella dell’osservazione madre—bambino, sia per la ricchezza di notazioni che da essa derivano, e sia perché l’esperienza di maternità e il sostegno dell’osservazione hanno rappresentato per la madre un momento realmente importante per l’elaborazione di una delicata problematica interna, che ha presentato significativi aspetti di un’evoluzione positiva. L’osservazione dello sviluppo della relazione tra madre e figlio è stata condotta secondo il metodo di E. Bick, arricchito da gli apporti di P. Borgogno e dai recenti contributi degli scritti di Genovese, Albergano, Ferraro, Petrelli, Adamo e Cesaro. E’ durata per tutto il primo anno di vita del bambino, con sedute settimanali della durata di un’ora ciascuna. Uno degli aspetti più significativi emersi dall’osservazione è stato il processo di adattamento reciproco tra il bambino JeanMarie e la madre JosiAnne. Giustamente gli autori di cui sopra sottolineano a questo riguardo che, se “l’attività del bambino muove essenzialmente dal bisogno di guardare nello specchio della madre per delimitare il suo sé”, ciò “comporta un rischio continuo che il processo si svolga per parziali falsificazioni del sé”. In effetti nelle discussioni che facemmo sul caso, una del— le preoccupazioni costanti fu che si potesse produrre un eccessivo adattamento del bambino alle modalità imposte dalla madre. Già nei due primi colloqui, nell’ultimo mese di gravidanza, JosiAnne aveva subito fatto emergere angosce collegate a sogni e fantasie di avere nella pancia e di poter partorire qualcosa di mostruoso. Dopo la nascita queste fantasie si sono trasformate in una difficoltà a far coincidere l’immagine reale del figlio con quella fantasticata. Il bambino le sembrava brutto, era un maschio mentre era attesa una femminuccia, aveva capelli molto scuri. La madre, francese, nella difficoltà a riconoscere il figlio, maschio, e per di più dai caratteri somatici così meridionali e lontani rispetto alla sua origine bretone, esprimeva il suo senso di solitudine e di esclusione, simbolizzato dalla sua continua preoccupazione di essere in un paese straniero. L’assistenza medica non le sembrava come quella del suo paese; si lamentava spesso delle differenti abitudini alimentari. Il suo desiderio di avere un femminuccia e la difficoltà ad accettare il figlio reale nascevano anche dalla necessità di rivivere in termini ricostruttivi e positivi la propria infanzia e la relazione con la propria figura materne particolarmente difficili e dense di ansie.JosiAnne aveva un rapporto totalmente disturbato con il cibo (sfociava di tanto in tanto in momenti di vera e propria anoressia, come nella sua infanzia) da non poter essere interiormente elaborato. Su questo si innestava una sorta di identificazione doppia; JeanMarie non poteva rappresentare che parti di lei stessa piccola (e non poteva perciò assolutamente mangiare), mentre lei stessa era ora la propria madre (e perciò pericolosa se avesse nutrito il bambino). In effetti il problema veniva “agito” inconsciamente sul figlio, nel senso che dopo soli pochi tentativi JosiAnne decise di allattarlo artificialmente. JosiAnne si preoccupava molto di essersi ingrassata e deformata, e che l’allattamento le avrebbe sciupato il seno. Quasi come se la parte minacciosa dentro di sé fosse ora trasferita nel figlio visto perciò come avido, capace di consumare e distruggere nella sua relazione oggettuale. In effetti si preoccupava spesso che anche il figlio fosse troppo grasso; le sembrava che mangiasse eccessivamente. Avevo la sensazione che in qualche maniera tenesse a freno la richiesta di cibo del bambino, come per preservare se stessa da questa ingordigia distruttiva, e al tempo stesso per bloccare le ansie sul mangiare e sulla crescita, entrambi legati alla modalità con cui aveva sviluppato la sua anoressia. Il fatto che il bambino fosse maschio, lungi dall’ostacolare il tentativo di ricostruzione positiva della propria vicenda infantile, ha fatto sì che JosiAnne non si identificasse totalmente nel le sue parti di bambina (come forse sarebbe avvenuto se avesse avuto una figlia), e che quindi non “agisse” soltanto le proprie dinamiche, ma che le riuscisse anche ad elaborare, seppur gradualmente, sin dall’inizio. La distanza che lei poneva tra bambino reale e bambino immaginato poteva essere colta anche nelle continue stimolazioni che dava al figlio, come per cambiarlo. Gli comprava giocattoli complicati una quantità di pupazzi, oggetti, libri sempre adatti a bambini più grandi, in un’ansia che lui crescesse e fosse in qualche misura riconoscibile come persona reale e viva. Immaginarlo più grande, come se potesse accelerarne così la crescita e il processo di separazione da lei, voleva dire per JosiAnne una liberazione dalle proprie fantasie angosciose legate alla prima infanzia. Gli faceva cambiare frequentemente gioco, cercando di tenere sempre desta la sua attenzione. Arrivò una volta persino a risvegliarlo quando stava addormentandosi nella culla, agitando il sonaglino che gli pendeva sul capo, fino a che Jean Marie non si rialzò e non riprese a giocare. Mi sembrava che uno stato di quiete, di gioco prolungato con lo stesso oggetto, di interesse tranquillo, non fossero tollerati da JosiAnne, e che solo l’attività evidente, lo star svegli, il cambiare frequentemente interessi, potessero darle una continua conferma che il bambino fosse vivo, della continuità della sua esistenza. Cogliendo la sottolineatura di Genovese, Albergamo e gli altri, secondo cui “il processo che sempre sottende ogni manifestazione dell’osservare è sia il risultato sia la replica della vicenda evolutiva del soggetto”, è interessante notare come questa evanescenza iniziale nel contatto con il bambino, JosiAnne la manifestasse anche con me. Mai sicura dell’ora e del giorno della prossima seduta, spesso li spostava, quasi riuscisse solo così a percepire la reale concretezza della mia presenza, fino a quando non mi accettò del tutto, e non accettò anche un’ora e un giorno alla settimana fissi. Il processo di adattamento reciproco (si dovrebbe dire prioritariamente del bambino alla madre) ha avuto una serie di tappe particolarmente significative. Sorprendentemente JeanMarie stava cambiando caratteristiche fisiche. I capelli stavano diventando biondo chiarissimo, e la madre glieli tagliava con la frangetta, come li portava lei da piccola; gli occhi divennero azzurro chiaro, anche il volto e gli zigomi si avvicinavano sempre più ai caratteri bretoni della madre. In un viaggio in Francia gli amici dissero a JosiAnne che JeanMarie era un piccolo bretone. Lei ne fu entusiasta. JanMarie sembrava adattarsi anche alle eccessive continue stimolazioni materne, mostrando un carattere irrequieto, desideroso dì nuovi giochi e nuovi oggetti, insofferente dopo un pò di quel che stava facendo. Addirittura, per un lunghissimo periodo, dormì poco la notte perché si svegliava e voleva giocare o fare qualcosa. Ma il bambino riusciva anche ad esprimere prepotentemente un proprio senso di disagio e di richiamo verso esigenze più primarie di contatto e manipolazione, attraverso un piangere frequente, continue irritazioni alla pelle. Mi sembrava che tentasse faticosamente di conquistarsi uno spazio suo, un proprio modo di essere, nonostante i forti elementi intrusivi e di fusione della madre. Mi aveva molto colpito nei primi mesi di vita un suo frequente sospirare a singhiozzi (come si fa in genere dopo un pianto o lento) sia quando era sveglio che quando dormiva. Pur non riuscendo a capire fino in fondo e razionalmente questa sua “comunicazione”, mi aveva sempre toccato emotivamente un senso di drammaticità e di fatica di vivere che vi scorgevo, quasi che il bambino tentasse di dare consistenza a un suo piccolo spazio di vita; a un tenue filo di continuità. E in effetti JeanMarie pur rispondendo alle aspettative della madre cominciò a soffermarsi su un’attività di gioco più a lungo, nonostante i richiami della madre per attirare la sua attenzione su altri giocattoli o su altre sue proposte. Questo fu più evidente ancora quando iniziò ad usare meglio e frequentemente la sua voce. Con le sue “lallazioni” è proprio come se parlasse, e in un più stretto contatto con le sue emozioni riusciva ad esprimere una ampiezza di sentimenti con molta profondità. Come quando, meravigliato di vedersi specchiato nel vetro del balcone, toccò la sua immagine con la mano e le parlò con un tono diverso dal solito e con molte dolci moine, così come fece con tre orsacchiotti di pezza con i quali aveva cominciato a dormire. La voce lo accompagnò anche in una specie di risatina (da adulti, la definiva JosiAnne) quando scoprì il piacere di masturbarsi e negli strilli, incredibili, quando a poco a poco riuscì ad arrabbiarsi con la madre. Nell’alternarsi all’interno della coppia madre—bambino di elementi di fusione e di controllo da una parte e sempre più di separazione dall’altra, JosiAnne riusciva poca a poco a riconoscere nel figlio che questi dava segnali evidenti di diventar più grande, un bambino reale. Rassicurata, potè immaginare di rivivere l’inizio della sua maternità, prima in una fantasia di una seconda gravidanza e poi in un’ammissione cosciente di rimpianto per quel primo periodo durante il quale non era stata “pronta ad avere un figlio e disponibile”. Allo stesso tempo potè lentamente distaccare il bambino dalla sua anoressia cosicché Jeanmarie, passato per le fasi di rifiuto di mangiare, di voracità e di abulia, era diventato più sereno con il suo rapporto con la pappa, che non era più caricata eccessivamente da altri problemi di relazione, che trovavano vie più complesse e strutturate per manifestarsi. Il bambino riusciva ad essere più oppositivo nei confronti della madre, spesso strillando con forza e determinazione, e questo aiutava ancor di più, JosiAnne a districarsi dalla confusione tra problemi suoi e aspetti del figlio. Questi ripresentò quel sospirone a singhiozzi solo nei momenti più difficili di richiesta— conflitto con la madre. Rassicurata, Josianne riuscì persino a cambiare il proprio rapporto con il cibo e a farsi vedere da me mentre mangiava, anche se il giorno prima o la mattina si era sentita “male”. JosiAnne aveva sempre avuto grossi problemi ad affidare il figlio a delle bambinaie. Ne aveva necessità per il lavoro; ma anche per “sottrarre” Jeanmarie alle proprie influenze negative (come madre). Aveva molta paura, però che potesse poi perdere il figlio, di essere in un certo senso sostituita. Questo vissuto ad un certo punto si modificò, si ribaltò. Infatti l’ultima cameriera—bambinaia, una ragazza inglese di colore, incarnò sempre di più tutti gli aspetti intransigenti, rigidi e moralistici, tipici della madre di JosiAnne, cosicché quest’ultima poté vederli in un certo distacco dall’esterno; poté vedere questa partì di sé finalmente oggettivate, riconoscerle come la causa delle influenze negative sul bambino, elaborarle (anche se non completamente) e sentirsi per un certo periodo più libera, vitale e creativa. Aver avuto un figlio (con le conseguenze che abbiamo esaminato) ed essere sostenuta da questa esperienza dell’osservazione producevano in JosiAnne un effetto benefico, che sì avvertiva anche nel processo di differenziazione madre—bambino. Questo processo viene infatti come “replicato” nel rapporto della madre con l’osservatore. Lo spazio psicologico tra i due non è vuoto o pericolosamente senza distanza, ma è riempito dall’esistenza del bambino; punto d’incontro della comunicazione ma anche elemento di separa zone. Questo permette alla madre di modulare la distanza della relazione, di confondersi o di separarsi, utilizzando la situazione di osservazione e riproducendo così il processo che anche il bambino vive nelle prime fasi di vita. Tutto ciò è facilitato dalla prevalenza nell’osservazione della comunicazione non verbale che, più che dare emozioni intense per mancanza di azione, esprime in maniera diretta le emozioni, senza le possibilità di difesa del linguaggio verbale: ammorbidire, mistificare, affermare e negare. L’elaborazione della fine dell’osservazione, cioè di una separazione con l’osservatore, ha favorito ulteriormente, per l’intensità della situazione emotiva connessa, l’elaborazione delle dinamiche interne di JosiAnne, e il cambiamento delle forme dl rapporto nell’osservazione stessa. Durante le ultime sedute, infatti, riutilizzò il bambino per esprimere attraverso di lui vissuti di profonda intensità emotiva. Mi accompagnò una volta col figlio in braccio fin fuori la porta, continuando a salutarmi a lungo, finché il bambino incominciò a piangere e lei poté rassicurarlo che io sarei ancora tornato. JosiAnne cercò anche di avere in modo più esplicito degli spazi per se stessa. Mi parlava di problemi suoi che non mi aveva mai rivelato, chiedeva consigli e aiuto. Si informava anche di mia figlia, come a riconoscere l’esistenza reale, di me, e anche di altri bambini oltre al figlio. Tollerò più volte che JeanMarie si allontanasse da noi, camminando a quattro zampe, e che se ne andasse anche in altre stanze, senza dovere necessariamente richiamarlo o andarlo a prendere, come invece aveva sempre fatto prima. Trovai particolarmente significativo che una volta riuscimmo a stare tutti e tre insieme, ma ciascuno anche con se stesso senza condizionarci l’un l’altro. Il bambino giocava per conto suo, ma vicino a noi, JosiAnne cantilenava delle nenie francesi, e io, sprofondato nella poltrona, mi sentivo proprio bene. Il fatto che ci stessero gli altri non aveva più la funzione di coprire un proprio vuoto interiore; e penso che ciò possa collegarsi con quella complessa capacità e problematica che Winnicott definisce “lo stare soli in presenza dell’altro”. A mio avviso, poter riconoscere sia l’osservatore che il bambino come persone altro da sé permette alla madre di distinguere in particolare tra quello che è suo e quello che è del bambino, e quindi di entrare in contatto con proprie parti infantili prima negate o scisse. JosiAnne riuscì ad esprimermi intensamente un senso di gratitudine per la mia presenza e l’aiuto che le avevo dato. Prima, come al solito, attraverso il bambino: una volta, mentre il piccolo guardava alternativamente me e il padre, disse che mi confondeva con il padre; che la mia figura, cioè, era stata importante per lui come per la coppia madre—figlio. Successivamente riuscì a esternarmelo direttamente, quando nella seduta finale mi accompagnò alla porta senza il bambino e mi espresse quanto fosse stata utile l’osservazione per lei, per sentire e capire tante cose. Riuscì inoltre a dare una collocazione conclusiva a questa separazione, sia proponendo che io potessi ripetere l’osservazione anche per un secondo figlio, sia organizzando una festa per i compleanno di JeanMarie a cui mi invitò con mia figlia, per salutarci anche al di fuori della situazione di setting. Indubbiamente credo che sia possibile concludere che l’elaborazione della separazione è stata un momento essenziale a tutto il rapporto, per la sua capacità di strutturare spazi nuovi di comunicazione e di catalizzare contenuti psichici della madre, prima dispersi e frammentari, in una sorta di restituzione simbolica.